La bora in testa, di Roberto Curci
Conversazione con Roberto Curci sulla nevrotica protagonista del suo recente romanzo: Trieste
La bora in testa, romanzo uscito nel marzo 2005 per i tipi della MGS Press, fotografa Trieste in tre momenti del suo burrascoso Novecento. Tre momenti critici: all’inizio degli anni Venti, città destabilizzata psicologicamente e incisa da aspri conflitti sociali, appena redenta da un’Italia che si sta consegnando al fascismo. Quindi i maturi anni Trenta, gli “anni del consenso” al regime di Mussolini in procinto di varare le leggi razziali, che nel ferire la comunità ebraica colpiscono anche una parte storica e quanto mai vitale di società triestina. E infine i tardi anni Quaranta, con la città uscita a pezzi dalla guerra, travolta da una girandola di occupazioni straniere e lacerata al suo interno dal conflitto nazionale, contesa fra Italia e Jugoslavia.
A legare insieme le tre scansioni temporali, che coincidono con le sezioni in cui è diviso il romanzo, è la personalità titubante del giornalista Filippo Leis, crepuscolare antieroe che assiste – di decennio in decennio, di sezione in sezione – al graduale falò dei suoi entusiasmi di gioventù. Intorno, una ridda di personaggi presi a prestito dalla storia della città: profili che stanno a metà tra il ritratto fedele e la trasfigurazione letteraria.
Autore dell’“impasto” è Roberto Curci, a lungo redattore e responsabile delle pagine culturali del quotidiano «Il Piccolo», già studioso di Marcello Dudovich e Marcello Mascherini, qui al suo esordio in narrativa.
Nel suo libro s’incontrano ampi scorci di storia sociale, preziosi ritagli di storia vissuta. Fra le tradizionali narrazioni di Trieste date dalle diverse culture politiche, e la storia quotidiana, minuta, che la gente ha subito sulla propria pelle, secondo lei fino a che punto esiste una discordanza?
"Il mio è innanzitutto un testo di fiction, in cui ho miscelato realtà e fantasia, e a volte distorto volutamente eventi e personaggi reali caricandoli in maniera disinvolta di difetti che non furono loro. Premesso questo, penso che la storia a Trieste sia vissuta spesso in modo allegramente inconsapevole; è un qualcosa che scorre attraverso di noi, o sopra di noi, e di cui non ci si rende bene conto. La storia rappresenta in parte una lacuna della mia formazione e quindi le mie considerazioni possono apparire un po’ banali. Tuttavia, mi pare ci sia una scarsa consapevolezza del flusso di eventi che hanno preceduto e condizionato le nostre esistenze. Anzi, a ben vedere una presa di coscienza a Trieste manca anche nel mentre le cose accadono. Non parlo solo dei nostri anni attuali, così “impaludati”, ma di alcuni eventi del nostro passato che sono avven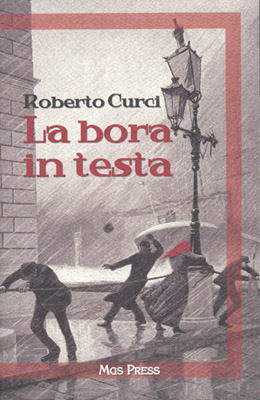 uti in forma e in misura stranamente indolore, considerata la loro enormità. Certamente molti cittadini tedeschi sapevano dell’esistenza dei lager, e ciò è testimoniato ormai da una vasta letteratura; ma così pure la Risiera fra i triestini, eppure quello fu un episodio – se episodio è la parola giusta – che passò come acqua su marmo nella coscienza della città, sia al momento della sua manifestazione, sia subito dopo, per poi approdare negli anni Settanta a un riconoscimento più che altro simbolico".
uti in forma e in misura stranamente indolore, considerata la loro enormità. Certamente molti cittadini tedeschi sapevano dell’esistenza dei lager, e ciò è testimoniato ormai da una vasta letteratura; ma così pure la Risiera fra i triestini, eppure quello fu un episodio – se episodio è la parola giusta – che passò come acqua su marmo nella coscienza della città, sia al momento della sua manifestazione, sia subito dopo, per poi approdare negli anni Settanta a un riconoscimento più che altro simbolico".
Destino diverso rispetto a quello delle foibe.
"Le foibe infatti sono un vulnus che ci si porta pesantemente dietro, il che dipende da un particolare orientamento politico-ideologico della città. Trieste è sostanzialmente manichea e sostanzialmente di destra, è molto anziana e conservatrice, molto immobile, con una memoria fondata su puntelli decisamente inamovibili. Ricordo che quando ero giovane e più ottimista, in un periodo di contrapposizioni politiche pure assai accese, credevo che i conflitti col tempo si sarebbero stemperati; sarebbe bastato aspettare un ricambio generazionale. Mi sembra che non sia stato così. Intendiamoci: è sacrosanto che la questione delle foibe non sia rimossa, e anzi vada sempre più studiata; solo mi limito a notare che alcuni fenomeni occupano oggettivamente lo spazio di un macigno nella memoria di Trieste, ed è una cosa che per fatti altrettanto gravi non avviene".
È come se la Risiera avesse inghiottito elementi sentiti quasi estranei e separati nella coscienza della maggior parte della città?
"Credo maliziosamente che dopo il famigerato Ventennio e il disastro della guerra, l’occupazione tedesca e la creazione dell’Adriatisches Küstenland siano state avvertite dalla maggioranza della popolazione come un male minore, tutto sommato compatibile con un certo orientamento psicologico e sentimentale. Alla fine, la Trieste dalla vecchia mentalità asburgica in qualche modo riusciva a rispecchiarsi nell’ordine del Reich; mentre non poteva assolutamente farlo nelle bande del IX Korpus che calavano scalze e straccione dall’altipiano. Era insopportabile pensare che potessero prendere il potere coloro che a Trieste erano stati dediti da sempre ai lavori più umili, i servitori e le serve senza istruzione – o meglio: che si presumeva fossero senza istruzione. C’è sempre stato quell’enorme complesso di superiorità del triestino italiano, per cui si negava – e si nega grandemente tuttora – che le popolazioni slave avessero una cultura e una loro storia, proprio mentre oggi rischiamo di essere scavalcati dalla duttilità e dalla vivacità dell’“incultura” – che ovviamente non è tale – dei nostri vicini. Chi mai si è sognato o si sogna di imparare lo sloveno a Trieste? Invece i vicini sono sempre stati bilingui, i giovani adesso addirittura trilingui perché quasi tutti conoscono perfettamente l’inglese, cosa che mi pare non si possa dire dei nostri ragazzi con uguale sicurezza. Insomma, ora il deficit è nostro".
Forse però fra le nuove generazioni qualcosa sta cambiando. Una situazione sfavorevole può anche avere i suoi vantaggi: nella debolezza generale di memoria storica è naturale che di molti aspetti del passato si vada perdendo traccia. O no?
"Forse. Dico forse perché ammetto di non avere il polso della situazione né di nutrire al riguardo un’attenzione particolare. Se è vero che non ci sono più certi attriti drammatici è anche vero, mi sembra, che una diffidenza persista e continui a essere fomentata. Non c’è più una guerra per bande nelle strade e un conflitto civile fra la popolazione, questo sì; ma non c’è neppure un clima di armonia o di sinergia fra le diverse parti. Naturalmente è una grossa perdita. Il confine “aperto”, la convivenza come risorsa: qui non vengono intesi come tali. Trieste è rimasta una città imbozzolata, ingessata e il dialogo non funziona non solo a livello di gruppi etnici ma proprio in assoluto. Basta uscire di casa e salire sul bus per incontrare gente livorosa, incazzata; amici miei di fuori, anche triestini che ritornano qui saltuariamente si stupiscono di ritrovare in questa civilissima città i soliti aspetti d’inciviltà, i soliti episodi di maleducazione e arroganza. Tutto ciò fa parte di uno stato d’animo generale e radicato, che ha essenzialmente a che fare con la nevrosi".
Nel primo episodio del suo romanzo, compare il personaggio di Attilio Bernstein, critico letterario e figurativo ricalcato sulla figura di Silvio Benco. Cito dal libro: Bernstein – siamo nei primi anni Venti – «aveva scritto pagine tremende sulla città vecchia, traboccanti esecrazione e disgusto, senza capire… la miseria, l’infelicità, la disperazione di tanta di quella gente». Anche qui: una città a compartimenti stagni, che non ha comunicazione fra le sue parti e dove perciò – come lei scrive – «l’ansia sempre incombe». Trieste è il “crogiolo mancato” di cui hanno parlato Bazlen e Apih?
"Indubbiamente c’è un equivoco sul termine crogiolo, che è qualcosa in cui elementi diversi si fondono; mentre qui nulla si è davvero amalgamato. Rimangono corpi ed entità separate; il sangue, è vero, si è molto mescolato ma ha creato delle mònadi. Anche in campo culturale, la ricchezza è grande ma unicamente nei suoi momenti individuali: ognuno chiuso nella sua torre d’avorio a scartabellare, ricercare, collezionare. Ci sono numerosi personaggi notevolissimi, che sanno tutto di un certo argomento e hanno raccolto informazioni magari strepitose, ma conosciute solo da loro e tenute dietro una porta blindata. C’è una separatezza endemica. In questa città la sintesi non arriva mai".
Torna Slataper: Trieste è «composta di tragedia».
"Sia per cattiva volontà che per suoi connotati psicofisici di base. A livello individuale e collettivo è assente la solidarietà. Tutti si gloriano della sua bellezza. D’accordo, ma che ce ne facciamo? Importa quello che c’è dentro, l’umanità o la disumanità che trovi dentro. Ci sarebbe bisogno di un ricambio profondo, una trasformazione epocale come quella del Settecento: da borgo patrizio delle saline a metropoli di un impero. Solo mi domando chi e perché dovrebbe invaderla questa volta. Una città vecchia, sempre più vecchia, in cui il sangue nuovo è quello portato dalle badanti non ha – mi pare – grandi prospettive. Ciò che conta alla fine è l’anagrafe, il dato demografico. E il riflesso di una delle tanti nevrosi triestine, peraltro, si coglie in questi anni nell’attività forsennata della lobby dei costruttori, che continua a tirar su palazzoni e centri commerciali per una popolazione in calo di tremila anime all’anno. Si favoleggia continuamente di nuove grandi aree, piene di negozi, cinema, ristoranti – tutto al plurale. Quando è già un problema riempire le pizzerie".
Badanti escluse, da dove può partire il rilancio?
"Aiuterebbe avere un’idea di sé: giusta o sbagliata che sia, un’idea comunque, a prescindere. Vogliamo puntare – dico per dire – sul mare, sul porto, sui musei, sul festival dell’operetta? Ci sono città, anche minori o minime, che hanno acquistato importanza perché sono state capaci di osare, di far convergere su una carta tutte le loro forze. Quando ha il suo festival della letteratura, per esempio, tutta Mantova ci ruota intorno, è unita, coopera al suo interno. L’indotto economico è eccezionale. Quante cose simili si potrebbero fare a Trieste? Ma dove mai potrebbe darsi la stessa coesione, lo stesso spirito collaborativo? Soprattutto in chiave transfrontaliera le opportunità non si conterebbero. Confine “aperto”, si diceva prima: se puntassimo – esempio banale – sul paesaggio e i prodotti del Carso, sulla bellezza della Grotta Gigante, non avrebbe senso farlo senza coinvolgere il Carso sloveno, senza collegarsi alle grotte di Postumia. Ma qui non si potrebbe mai arrivare a tanto. Il punto è sempre quello: la divisione".
Silvio Benco, Vito Timmel, Diego de Henriquez, Carolus Cergoly, Anita Pittoni, Eleonor Fini, Haydée, Pia Rimini, Doro Finzi… solo alcune delle personalità realmente esistite che lei ha trasformato in personaggi del suo libro. Da dove viene questa grande attenzione al “sottobosco”, diciamo così, della cultura triestina?
"Per il mio lavoro giornalistico e per mie ricerche personali, sono stato immerso per decenni nella dimensione culturale cittadina, in cui ci si incrocia sia con i grandi – spesso logorati ormai dall’uso e dall’abuso che se ne è fatto – sia coi cosiddetti minori. Alcuni dei quali non lo sono per nulla, avendo ricevuto riconoscimenti anche internazionali; altri invece sono rimasti effettivamente nell’ombra, misconosciuti ai più. Non ho fatto che mettere in uno shaker quelli fra loro che mi hanno maggiormente incuriosito. Le arbitrarietà, a volte gli anacronismi non sono pochi: il Timmel che si ritira in città vecchia per esempio è posteriore agli anni Venti; va un po’ posticipata cronologicamente anche la Carlotta de Jurco del primo episodio, personaggio molto poco noto in città, ma storicamente reale, che ho cercato di ritrarre fedelmente – a parte la tragica fine che le faccio fare. Ho tentato un ritratto fedele anche del pittore Arturo Nathan, benché nel libro gli abbia attribuito una malefatta del tutto inventata, il che mi ha spinto a modificargli il cognome in Nacson (sopravvive una sua lucidissima sorella centenaria, che spero non abbia letto o recepito). Come ho detto, giocare tra realtà e fantasia è stato il divertimento dello scrittore, e spero eventualmente del lettore".
«La bora in testa»: come mai questo titolo?
"A libro pubblicato, una mia amica – la gallerista Nadia Bassanelli – mi ha ricordato che La bora in testa era un’espressione che avevo già utilizzato una quindicina d’anni fa, per un articolo su Vito Timmel; voleva essere metafora degli sconquassi che attraversavano la mente del pittore. Il bello è che mi ero dimenticato della vicenda: anch’io ho i miei refoli".
Anche il protagonista Filippo Leis si pone tra storia e invenzione?
"Diciamo che è la summa di alcuni lati – tra lo sfigato e il mentalmente perdente – incontrati in tanti colleghi giornalisti. È il prototipo del giornalista idealista che finisce sconfitto: dalla vita, dal lavoro, dall’amore. E dalla sua città".
Patrick Karlsen






