De profundis, di Salvatore Satta
Salvatore Satta scrive il De profundis tra il giugno del ’44 e l’aprile del ’45. Si trova a Pieris d’Isonzo, un paesino della campagna friulana, situato circa a metà in linea d’aria fra Udine e Trieste. Si tratta di una sistemazione di fortuna. I bombardamenti alleati hanno distrutto la sua abitazione di Genova; di lì a qualche mese sarebbe stato nominato Prorettore dell’Università di Trieste. È sardo, ha quarantadue anni. È un giurista affermato. Non è pubblicamente noto invece il suo talento per la narrativa; del resto lui stesso vi si abbandona con severa estemporaneità. Al suo attivo ha già un romanzo, La veranda, che come il suo capolavoro, Il giorno del giudizio, e così il resto della sua produzione extragiuridica, verrà pubblicato postumo. Il De profundis offre pagine che si aprono di tanto in tanto in squarci narrativi d’incantata bellezza, ma non è un romanzo. È un’estrema, straziante, struggente meditazione sul destino dell’Italia, colta allo scoccare di ore decisive. Fra queste Satta non ha dubbi che vi sia stata la più terribile, e, forse primo fra tutti, è persuaso di doverle dare coerentemente il nome che le spetta. La data dell’8 settembre 1943, egli afferma, coincide con la morte della patria:
«La morte della patria è certamente l’avvenimento più grandioso che possa occorrere nella vita dell’individuo. Come naufrago che la tempesta ha gettato in un’isola deserta, nella notte profonda che cala lentamente sulla sua solitudine egli sente infrangersi ad uno ad uno i legami che lo avvincono alla vita, e un problema pauroso, che la presenza viva e operante (anche se male operante) della patria gli impediva di sentire, sorge e giganteggia tra le rovine: il problema dell’esistenza» (pp. 16-17).
Niente meno che il problema dell’esistenza. In realtà, a dispetto dell’apparenza esorbitante, la sua esposizione può essere svolta in termini abbastanza semplici. Proveremo a dire così: quando al soggetto vengono recisi i legami con la comunità, la quale è fatta di sue consuetudini, di sue norme, di sue memorie, di una sua identità collettiva, il soggetto resta solo, parte scevra dal tutto, e restando solo non può non interrogarsi sulle ragioni e sul senso della sua identità individuale. Sulla sua esistenza, appunto.
Delle cose finora discusse, quali sono accadute alla nostra Italia dalla destituzione di Mussolini, nel luglio del ’43, al termine della guerra nell’aprile del ’45? Senz’altro le pessime, dice Satta, con argomenti dolorosi quanto convincenti. Per inquadrarne a dovere la scansione, però, è necessario tornare agli albori della tragedia, al costituirsi del regime che condusse il paese alla guerra. Il fascismo infatti ha segnato, nella formula dell’autore, la «critica dell’uomo tradizionale». Dove critica va recepita come apice, punto più alto della parabola, e uomo tradizionale sta a sinonimo di individuo moderno: colui che ha definito i suoi crismi giuridici nella rivoluzione francese, mentre in quella industriale ha trovato la sua missione sociale e i suoi orizzonti economici. In una parola, il borghese.
Attraverso la giurisprudenza, fatta ruotare intorno al principio di libertà, l’uomo tradizionale aveva modellato la sfera sociale a suo piacimento. Ma la libertà borghese, nota Satta, era puramente formale, e cioè falsa, celando nient’altro che il tentativo di universalizzare gli interessi, parziali, della classe sociale che l’aveva elaborata. «Lo spirito della legge stava nello scambio delle libertà primordiali, ma scomodissime, di ammazzare e di rubare, con la libertà di impadronirsi, sotto determinate condizioni, dei beni del mondo» (p. 36). Le leggi insomma erano lo strumento adoperato dall’uomo tradizionale per garantirsi la sicurezza e la ricchezza. Né rispecchiavano alcun principio universale, anzi, servivano alla difesa di un privilegio particolare, del tutto alieno alla libertà sostanziale: la libertà che Satta identifica con quella cristiana, «fatta di rinuncia e di sacrificio di sé». Chi ha la fortuna di possederla, assicura il giurista, giunge a capire «il significato delle spaventose conflagrazioni che divorano l’umanità» (p. 79). E forse, meglio di altri, capisce anche in quale misura l’uomo tradizionale fosse disposto a rinunciare allo “schermo” della falsa libertà, allorché le masse sfruttate avessero preteso i suoi medesimi privilegi, dai quali programmaticamente venivano escluse. Nelle parole di Satta, «il concetto stesso di libertà-privilegio postulava che la libertà dovesse essere sacrificata quando il privilegio fosse stato conteso, come uno strumento ormai inutile» (p. 34). È esattamente quanto accadde in Italia col fascismo, all’altare del quale l’uomo tradizionale sacrificò sì la sua libertà, ma anche la sua integrità personale, in cambio di una tavola imbandita. «Nella 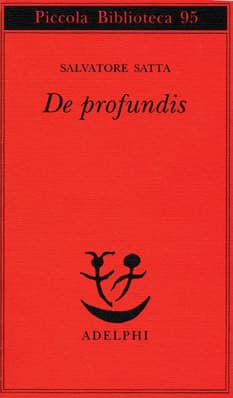 sua indifferenza alla vita del tutto – ricorda ancora l’autore – e cioè nell’assenza di un sentimento vero dello Stato, egli aveva costruito le sue relazioni con questo sulla base di un rapporto creditorio... coi carabinieri, con le dogane, con la corruzione magari, e lasciando che la sua vita interna ed esterna andasse per il resto come voleva» (p. 139).
sua indifferenza alla vita del tutto – ricorda ancora l’autore – e cioè nell’assenza di un sentimento vero dello Stato, egli aveva costruito le sue relazioni con questo sulla base di un rapporto creditorio... coi carabinieri, con le dogane, con la corruzione magari, e lasciando che la sua vita interna ed esterna andasse per il resto come voleva» (p. 139).
Come voleva: ma con un limite ben preciso. L’uomo tradizionale, non a caso, ritenne sciolto automaticamente il patto nel momento in cui il suo duce lo trascinò in guerra. O un po’ più tardi: non appena fu messo in grado di percepire, di quella guerra lontana, gli effetti materiali e vicini, sotto la pioggia delle bombe inglesi e americane. Fu allora, con la messa a repentaglio dei suoi averi, con la progressiva devastazione economica, che egli si sentì tradito. Di certo la guerra non l’aveva desiderata, poiché nessuno come lui avrebbe amato godersi la pace. Ma proprio le sue fondamenta essenzialmente egoistiche conferivano alla pace una nota torbida, che giocava quanto mai in favore della guerra. Con accenti che sfondano l’apocalittico, e che rivelano appieno le sue ascendenze culturali, Satta ragiona: «non era già la pace dello spirito, che è sinonimo di libertà, ma era la pace dell’istinto appagato, che è affermazione feroce di sé, negazione degli altri e di Dio». A monte vi stava «il feroce possesso che oppone uomo a uomo, e fa di ogni uomo il centro dell’universo... La guerra non è che l’espiazione di questo possesso. Perciò è logico, è giusto che essa si abbatta su di noi e sugli oggetti del nostro amore» (p. 92).
Difficile che l’uomo tradizionale arrivasse a produrre considerazioni così fosche su di sé; si limitò dunque a sperare ardentemente in una veloce liquidazione del regime, con lo stesso spirito opportunistico con cui per vent’anni vi aveva aderito. E non parve neppure allarmarsi troppo del fatto che a una sconfitta del regime dovesse seguire per forza la sconfitta della patria. L’Italia insomma si trovava all’imbocco del tunnel: e ci si buttò a capofitto, esultando ad ogni battaglia perduta, attendendo con turpe voluttà la notizia di un’altra città bombardata, e coltivando sentimenti d’incresciosa ammirazione per il nemico, quell’inglese più evoluto, più bello, soprattutto più ricco. Satta descrive la cupido dissolvendi italiana con parole scabrose, fin nauseanti, quasi identiche – com’è stato osservato – a quelle utilizzate da Corrado Alvaro nel pamphlet L’Italia rinunzia del 1944. Si faccia caso di come Alvaro stendesse i suoi tristi scritti al Sud, e Satta al Nord: disprezzo e vergogna di sé, autolesionismo, erano allora pulsioni unitarie.
Un paese ghermito da un’incontenibile voglia di sconfitta, dunque; che forse non è immediatamente coincidente con la voglia di morire, ma di sicuro lo è con la rinuncia totale a opporre resistenza a che ciò accada. L’unica cosa comunemente bramata era il ritorno all’egoistica ed edonistica pace d’anteguerra. Ciò fu causa d’esiziali errori di prospettiva. La congiura di palazzo che provocò la caduta di Mussolini, il 25 luglio ’43, fu salutata come la fine del conflitto, e ancor più lo fu l’armistizio dell’8 settembre: il giorno della resa, del tradimento e del cambio di fronte, della fuga del re e di Badoglio, dell’esercito lasciato senza comando, della dissoluzione di ogni potere pubblico.
E della morte della patria. Essa morì quel giorno perché quel giorno, Satta scrive, iniziava la guerra, ma gli italiani in maggioranza disertarono: la vera guerra, «che dal piano internazionale e nazionale si [era] spostata al piano individuale» (p. 186). L’unico modo per conservare un minimo di dignità, che pure era il solo capace di portare rapidamente alla pace, sarebbe stato continuare a combattere. La minoranza che lo fece, col suo gesto gettò il seme di una patria rinnovata. Ma combattere contro chi? Contro i tedeschi, il nemico di oggi? O contro gli angloamericani, il nemico di ieri? La risposta di Satta è la più difficile: contro se stessi. Bisognava lottare contro il proprio egoismo, contro l’uomo tradizionale che ciascuno sempre coltiva dentro di sé; scavare a mani nude dentro la propria coscienza, affinché ciascuno comprendesse d’aver speso la vita nella cieca difesa dei propri interessi, e d’averli posti – nella maggioranza dei casi – sotto la ventennale tutela di un potere violento.
La scelta di campo sarebbe venuta da sé. Comunque, adempiuto fino in fondo all’esame, in un certo senso avrebbe perso d’importanza. Ognuno è prigioniero del suo angolo di visuale – suggerisce Satta – del suo senno «unilaterale e sempre fallace», e quale uomo è tanto sapiente e forte, da negare nell’altro la sincerità, al di là di evidenti casi limite, numerosi quanto si vuole? Da abiurarne con assoluta sicurezza le scelte, a priori, solo perché hanno spinto nella direzione opposta – magari per effetto di una stupidissima divergenza nell’interpretazione dei medesimi valori, o peggio, per una qualunque bizza del destino. La persona, che sia virtuosa, non si sottrarrà alla constatazione della sconfitta, alla valutazione delle sue ragioni profonde, all’autocritica. Non si deve fraintendere il discorso di Satta, anche se è facilissimo farlo, e appunto è stato fatto. Il De profundis è colmo di disgusto nei confronti del fascismo, e trabocca d’odio verso il nazismo. È però un testo finissimo di morale, e come tale non può non rifuggire dai giudizi netti quando la nettezza impedirebbe la comprensione delle cose e degli animi, la più ampia possibile. Reca soprattutto lo sgomento verso quella che è stata la condotta della più grande parte degli italiani, che si sono rifugiati dietro una vile, e ancora una volta interessata, abdicazione al loro dovere morale; che hanno optato, anche dopo l’8 settembre, per la perpetuazione di una loro privata non belligeranza.
La “zona grigia”, oggi tanto cara nella valutazione di certo revisionismo, è ciò che scagliò Satta nel suo sconforto allucinato. La massa informe e pervasiva degli uomini tradizionali, sopravvissuti a tutto e a se stessi, che non pagarono alcun prezzo, e si diedero ai saccheggi delle caserme, lucrarono nel mercato nero, si impossessarono – facendola a pezzi – della «roba di Badoglio». Così fu detta, con sintomatiche implicazioni, qualunque cosa avesse avuto una parvenza pubblica, utile o inutile che fosse, dai mezzi di trasporto, alle fabbriche abbandonate, giù in una spirale di bestiale dissipazione del sé e dell’altro da sé, fino alle piante:
«Cominciò la povera gente che cercava rami e foglie per il focolare spento, ma subito essa fu sopraffatta e travolta da folle organizzate ed esperte del mercato nero, che in pochi mesi rasero al suolo intere foreste di parchi, di giardini, di viali, le testimonianze secolari dell’amore che ciascuno ha per il proprio villaggio, per la propria città, per la propria patria... Allora sono tornato a casa, ho chiuso le imposte per non sentire lo schianto degli alberi che crollavano, e in memoria di tutti gli uomini che muoiono, di tutte le piante che cadono, di tutte le cose che finiscono, ho riletto il canto del dolore e della speranza: De profundis clamavi ad te, domine» (pp. 188-89).
Patrick Karlsen
EDIZIONE ESAMINATA E BREVI NOTE
Salvatore Satta, De profundis, Adelphi, Milano 2003 (I ed. 1980).
Salvatore Satta (1902-1975), giurista e scrittore italiano.






