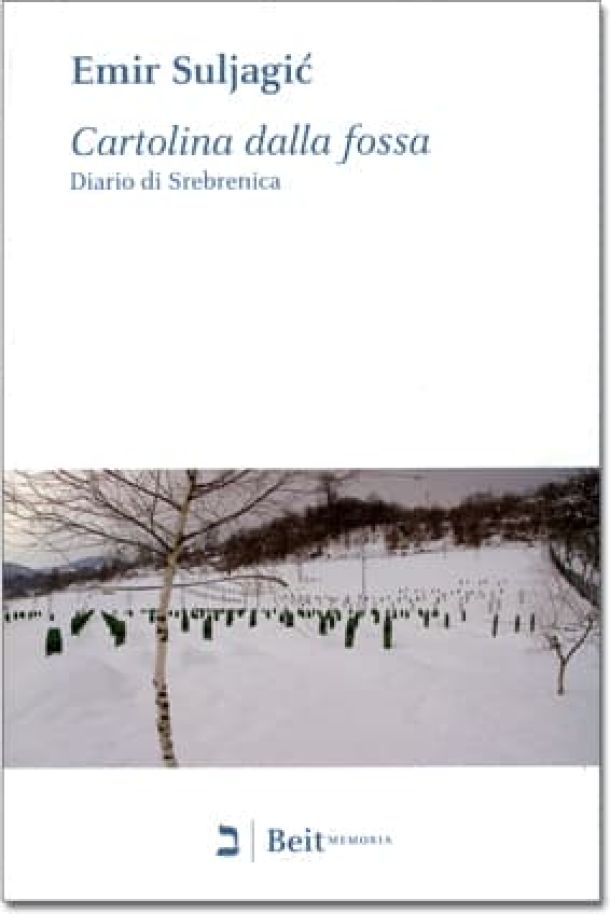Mattatoio n.5 di Kurt Vonnegut
«Dresda era tutta una sola, grande fiammata. Quell’unica fiammata stava divorando ogni sostanza organica, ogni cosa capace di bruciare.
Non fu prudente uscire dal rifugio fino a mezzogiorno dell’indomani. Quando gli americani e le loro guardie vennero fuori, il cielo era nero di fumo. Il sole era una capocchia di spillo. Dresda ormai era come la luna, nient’altro che minerali. I sassi scottavano. Nei dintorni erano tutti morti» (p. 164).
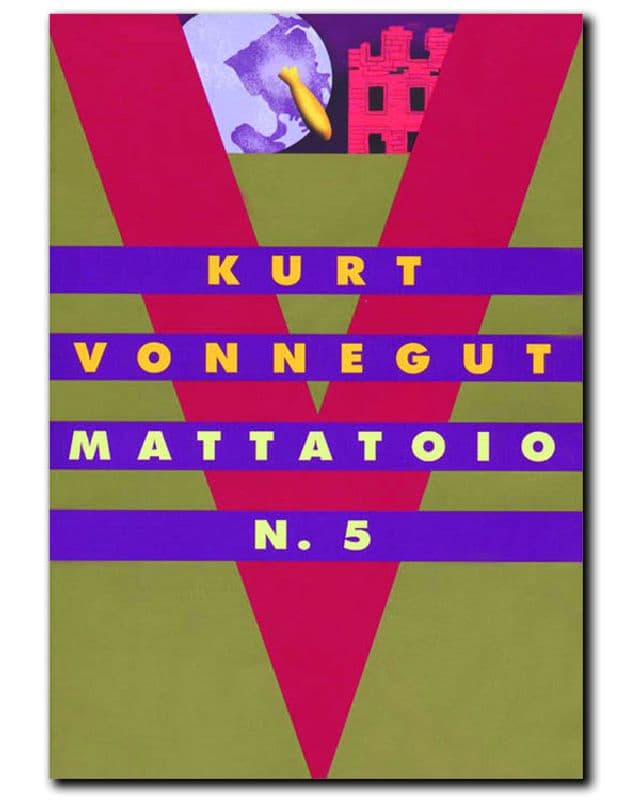 Fu distrutta, Dresda, la notte del 13 febbraio 1945. La Germania era già in rotta da un po’: i fronti avevano iniziato ad inghiottirne i bambini. Solo due mesi e due settimane dopo, in un bunker sotto Berlino, ci sarebbe stato il suicidio di Hitler. L’obiettivo principale degli Alleati, giunti a quel punto, era di finire la guerra il prima possibile. I comandi diedero avvio, allora, ad una serie di operazioni ad altissimo valore simbolico, che avevano la finalità di annientare il nemico sotto il profilo psicologico, e di condurlo ad una resa più celere. La valenza strategica di Dresda, in un’ottica militare, stava tutta qui. Non era uno snodo ferroviario cruciale, né un grande porto, non era neppure un centro amministrativo d’importanza nazionale. Era solo una città tedesca di media grandezza, che però aveva la ventura di essere una delle più incantevoli d’Europa; certamente la più bella del suo paese. Era detta la Firenze dell’Elba.
Fu distrutta, Dresda, la notte del 13 febbraio 1945. La Germania era già in rotta da un po’: i fronti avevano iniziato ad inghiottirne i bambini. Solo due mesi e due settimane dopo, in un bunker sotto Berlino, ci sarebbe stato il suicidio di Hitler. L’obiettivo principale degli Alleati, giunti a quel punto, era di finire la guerra il prima possibile. I comandi diedero avvio, allora, ad una serie di operazioni ad altissimo valore simbolico, che avevano la finalità di annientare il nemico sotto il profilo psicologico, e di condurlo ad una resa più celere. La valenza strategica di Dresda, in un’ottica militare, stava tutta qui. Non era uno snodo ferroviario cruciale, né un grande porto, non era neppure un centro amministrativo d’importanza nazionale. Era solo una città tedesca di media grandezza, che però aveva la ventura di essere una delle più incantevoli d’Europa; certamente la più bella del suo paese. Era detta la Firenze dell’Elba.
La sua distruzione totale, si pronosticava, avrebbe infiacchito senza rimedio il morale del popolo tedesco. Non bastava cioè che vi entrassero le truppe sovietiche, le quali al momento del raid erano posizionate a venti, trenta chilometri dalla città. Gli americani erano dell’avviso che fosse necessario spazzarla via, letteralmente, per dare una dimostrazione inequivocabile della loro superiorità militare, anche agli occhi dei russi. Gli inglesi volevano che la Germania avesse la sua Coventry. E così fu fatto. Nello spazio di poche ore morirono 135.000 esseri umani. (La bomba atomica lanciata su Hiroshima, la più nota ostentazione muscolare di quei mesi finali di guerra, ne uccise 71.379.)
In mezzo alla manciata di superstiti, che nelle tarde ore del mattino successivo mossero i primi passi in quello scenario di parvenza lunare, vi era un ragazzo di ventidue anni, soldato dell’esercito americano, benché il suono del nome ne rendesse lampanti le origini tedesche. La famiglia di Kurt Vonnegut infatti era emigrata negli Stati Uniti, appena tre generazioni prima. Lui fece ritorno nella terra che era stata dei suoi bisnonni, ma perché mandato a combatterla. Durante la battaglia delle Ardenne, il suo reparto finì per sbandarsi tragicamente. Insieme a un centinaio d’altri disperati, vagò per chilometri fra distese di neve finché venne intercettato dalla milizia tedesca, che lo fece prigioniero e gli evitò l’assideramento.
Fu dapprima portato nel settore inglese di un campo di sterminio per prigionieri di guerra russi. I britannici, che stavano lì da parecchio tempo e avevano trovato di già un loro modus vivendi, non perdevano occasione di esternare sentimenti di pena mista a disprezzo, verso gli straccioni americani appena arrivati. Alcuni convenivano coi tedeschi sulla generale dabbenaggine del popolo statunitense. «Fiacchi, puzzolenti, sempre pronti a piangersi addosso: una massa di bastardi piagnucolosi, sporchi e ladri … sono peggio dei russi, maledizione»: parole di un graduato inglese. Era sollazzo comune ai carcerieri tedeschi e ai reclusi inglesi la lettura di un rapporto sul comportamento dei prigionieri di guerra americani in Germania, redatto da un ex americano passato ai nazisti, Howard Campbell jr. Conteneva analisi al cianuro sulla società d’oltreoceano, descritta come degenerata dal capitalismo, improntata a nessun’altra gerarchia che non fosse quella del denaro, imbevuta di individualismo e di falsi modelli di autorealizzazione, flagellata da una massa di poveri invidiosi della minoranza ricca e ignoranti. Vi era scritto: «Questi poveri non si amano l’un l’altro perché non amano se stessi. Una volta capito questo, lo sgradevole comportamento dei militari americani nei campi di prigionia tedeschi cessa di essere un mistero». E: «Il responsabile di un campo di prigionia che per la prima volta abbia a che fare con militari americani deve stare in guardia: non si aspetti amore fraterno, nemmeno tra fratelli. Non ci sarà nessuna coesione fra i singoli» (p. 123-124).
Questa denigrazione specchiava un senso di superiorità, diffuso fra le potenze della vecchia Europa nei confronti dell’ultima ammessa al circolo delle grandi, prepotente parvenu che da qualche tempo aveva il vezzo irritante d’atteggiarsi a prima della classe. Ma non solo: era anche il riflesso della radicata difficoltà a capirsi, da sempre rintracciabile nei rapporti fra le due sponde dell’Atlantico. Era il peso dei secoli della cultura europea, con le torsioni del suo pensiero, le sue zone d’ombra, i suoi inabissamenti, messo di contro alla leggerezza storica e al pragmatismo dell’America, coi suoi accenti sul fare e sulla vita come conquista, come innalzamento, accumulo di beni, arricchimento. Questi passi del romanzo aiutano ad intendere come l’idea di “Occidente”, nell’accezione strettamente contemporanea, fosse ancora di là dal formarsi. O meglio, c’era già un’idea di Occidente, però non costruita e assestata quasi totalmente sui (dis)valori del mercato, quale invece è quella attuale.
Ma torniamo alle peregrinazioni di Vonnegut. Il soggiorno al campo non dura molto. I prigionieri americani, che i tedeschi sembrano tenere in conto alla stregua dei polacchi e degli altri europei dell’est, cioè più o meno come la feccia del mondo civilizzato, appena un gradino sopra i russi, vengono destinati ai lavori forzati. C’è una città che insieme ad altre pochissime in Germania non è stata toccata dai bombardamenti, la cui attività produttiva è assolutamente intatta, e che quindi ha un gran bisogno di manodopera: Dresda. Il capo degli inglesi, tutti sollevatissimi per la partenza dei fetenti americani, li saluta con un breve discorso: «Io vi invidio, ragazzi … sarete in un posto dove c’è movimento e dove il cibo sarà sicuramente più abbondante … non dovrete preoccuparvi delle bombe, fra l’altro. Dresda è una città aperta. È indifesa e non ci sono industrie belliche o concentramenti di truppe di una certa importanza» (p. 137).
Era proprio così, e gli americani erano piuttosto contenti di andarvi. Appena smontano dal treno merci, e hanno modo di scorgere i primi angoli delle sue magnifiche strade e piazze, ne rimangono estasiati: «Il suo profilo era intricato, voluttuoso, incantato e assurdo» – afferma Vonnegut (p. 139), i cui occhi avevano contemplato prima d’allora le ferrigne avenues della sua città natale, Indianapolis, e basta. Dalla stazione, lui e gli altri prigionieri statunitensi vengono subito dislocati nel deposito carni del mattatoio n. 5 di Dresda: una specie di grotta incavata sottoterra, nella quale trascorreranno la notte del 13 febbraio. Vi usciranno a mezzogiorno della mattina dopo, e sarà come andare a spasso sulla superficie della luna.
Fra di loro vi era un uomo, Billy Pilgrim, che aveva già assistito infinite volte alla distruzione della città. È il protagonista del romanzo, l’alter ego di Vonnegut – il quale, per riuscire a raccontare la follia di Dresda, evidentemente non ha potuto fare a meno di frapporre tra sé e i suoi ricordi una figura fittizia, dotata di un potere paranormale confortante, a prima vista. Billy Pilgrim infatti è capace di viaggiare nel tempo, di vivere e rivivere all’infinito i diversi momenti della sua esistenza, procedendo – come dire – a sobbalzi lungo la linea dei suoi stati di coscienza. Ogni cosa è destinata ad essere per sempre, il futuro e il passato essendo illusioni della nostra soggettività: ne consegue che la morte è un evento di natura immaginaria, nel senso che l’individuo apparentemente morto in realtà continua ad esser vivo, chissà dove nello spaziotempo. È quanto Billy ha appreso dagli abitanti del pianeta Tralfamadore, dai quali è stato rapito dopo la guerra. Lo scopo immediatamente consolatorio della teoria è chiaro: applicata al caso di Dresda, significa che i 135.000 disgraziati caduti sotto il bombardamento sono ancora vivi in qualche altra dimensione; e altrettanto vale per qualsiasi essere umano morto in circostanze ingiuste.
Ma, c’è un ma. La medesima teoria racchiude implicazioni assai meno rinfrancanti. Basta osservare la metà mezza vuota del bicchiere, e ci si rende conto che – ancora nel caso specifico di Dresda – è come se il bombardamento avvenga in ogni istante, e tutti i suoi abitanti continuino a morire. Il male che è accaduto non cessa mai d’accadere; coesiste al presente, e sempre si ripete. Naturalmente, Vonnegut è al corrente della dark side sottintesa fra le pieghe della dottrina tralfamadoriana del tempo: «Se è vero quello che Billy Pilgrim ha imparato dai tralfamodoriani, e cioè che noi tutti vivremo in eterno, indipendentemente dal fatto che ogni tanto possiamo sembrare morti, non ne sono poi così felice» (p. 193). Sarebbe la concreta realizzazione di quanto avviene nella sua mente da circa sessant’anni, dove probabilmente le bombe di Dresda non hanno mai smesso di cadere. E la metafora, veridica, autentica, del fatto che la storia, tutta la storia è sempre storia contemporanea.
«Non vi dirò quanto mi è costato, in soldi, tempo e ansietà, questo schifoso libretto. Ventitré anni fa, quando tornai dalla seconda guerra mondiale, pensavo che mi sarebbe stato facile scrivere della distruzione di Dresda, dato che non avrei dovuto fare altro che riferire ciò che avevo visto. E pensavo anche che sarebbe stato un capolavoro o per lo meno che mi avrebbe fatto guadagnare un mucchio di quattrini, dato che il tema era così forte. Ma allora non mi venivano molte parole da dire su Dresda, o almeno non abbastanza da cavarne un libro. E non me ne vengono molte neanche ora, ora che sono diventato un vecchio rudere con i suoi ricordi e le sue Pall Mall e i figli grandi» (p. 12).
Patrick Karlsen