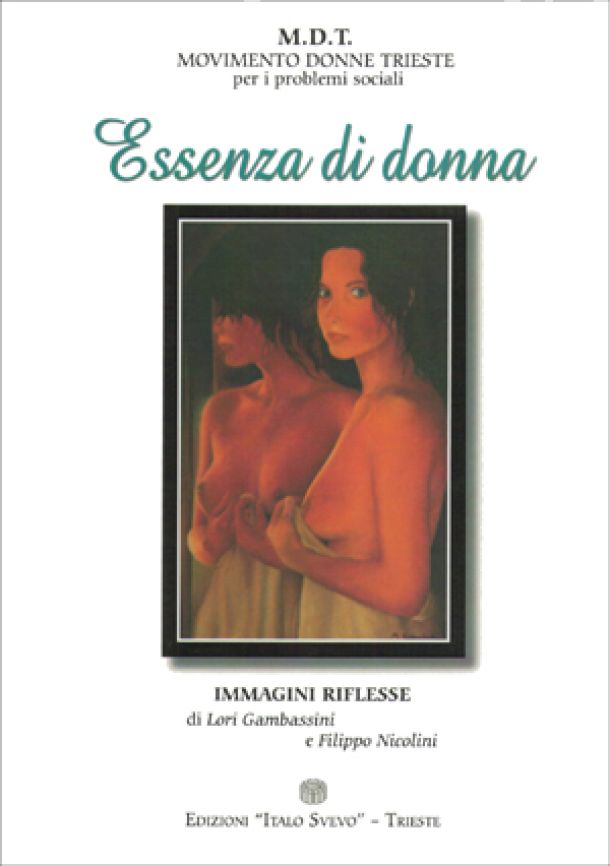Il libro perduto, di Enzo Bettiza
C'è chi vede, acutamente, nelle ripetizioni consce o inconsce, nei continui ritorni di certi scrittori su luoghi, personaggi, temi, affrontati e descritti magari ricorrendo a frasari simili o addirittura identici; c’è chi vede in queste irrimediabili cadute nell’imperfezione, nelle conative concessioni alla propria nevrosi cui non sfuggono alcuni autori, non un limite ma una ragione d’interesse – e di più: la manifestazione delle ossessioni e dei rovelli che appartengono a ogni grande romanziere.
Tic e manie che sarebbero fra le precondizioni necessarie, fra le più affidabili segnalazioni della presenza di un’indole artistica autentica. Come dire che un vero scrittore è sempre anche una mente disturbata e irrisolta.
Dopo aver letto Il libro perduto, si può affermare che l’opera narrativa di Enzo Bettiza denoti il tratto problematico appena accennato. La percorrono le luci e le ombre che circonfondono le espressioni di un qualunque genuino talento. Se la trama del romanzo, per la sua gran parte, si snoda in una città mai menzionata di una terra chiamata Illiria, è alquanto agevole riconoscere, dietro l’innominata città, la Spalato che ha dato i natali all’autore, e dietro la trasognata Illiria una concreta Dalmazia: i luoghi che egli ha già doviziosamente ricostruito in Esilio, sfavillante e al contempo dolente memoir pubblicato nel 1996. Inoltre, lampanti analogie si riscontrano fra i protagonisti de Il libro perduto e quelli di altri precedenti lavori di Bettiza. Chi h a già apprezzato Il fantasma di Trieste, e ricorda ancora il mefitico Maestro Pfeffer, non potrà fare a meno di sorridere, sorpreso come di fronte a una vecchia conoscenza ritrovata dopo anni, imbattendosi ora nel Maestro Perty. Il quale ricalca del precedente sia il percorso di formazione pittorica: un azzardato guazzabuglio di cubismo, espressionismo, surrealismo; sia l’intercalare mellifluo e un po’ snervante, n’est-ce pas?, mutuato dai trascorsi parigini; sia infine la memorabile malattia alle ossa che ne piega il fisico in dolorose e vieppiù grottesche contorsioni.
a già apprezzato Il fantasma di Trieste, e ricorda ancora il mefitico Maestro Pfeffer, non potrà fare a meno di sorridere, sorpreso come di fronte a una vecchia conoscenza ritrovata dopo anni, imbattendosi ora nel Maestro Perty. Il quale ricalca del precedente sia il percorso di formazione pittorica: un azzardato guazzabuglio di cubismo, espressionismo, surrealismo; sia l’intercalare mellifluo e un po’ snervante, n’est-ce pas?, mutuato dai trascorsi parigini; sia infine la memorabile malattia alle ossa che ne piega il fisico in dolorose e vieppiù grottesche contorsioni.
Le somiglianze, gli echi, le reminescenze non finiscono qui. Tanto che ritengo abbastanza calzante parlare di un universo bettiziano, dalla geografia e dall’umanità definite e sfuggenti insieme. Dove la tavola degli elementi primi dà vita a una serie variabile, ma sempre circoscritta e identificabile, di combinazioni; un universo di memoria e di sogno, che quasi pretende – direi – l’aggettivo di ectoplasmatico, i cui fantasmi s’impongono di volta in volta con alternanza, e insieme ricorrenza, di forme. Un universo perduto che ha dovuto attendere il suo corrispondente libro perduto, per essere compiutamente narrato e sviscerato. Mai prima d’oggi, infatti, le componenti cicliche nell’opera di Bettiza avevano raggiunto l’equilibrio di quest’ultima manifestazione. Ancora in Esilio troviamo una traccia di lettura, che col senno di poi suona come un preannuncio: quando vi si racconta che il memoir era sorto per effetto di un’incontrollata esplosione, intervenuta nel nucleo narrativo di quello che era nato come un romanzo e doveva diventare, nelle intenzioni dell’autore, il romanzo definitivo, il punto culminante e sintetizzante della sua parabola artistica. Ma l’urgenza autobiografica, lì, sollecitata dall’inaudita violenza degli eventi bellici che squassavano in quel periodo la sua Dalmazia e la Jugoslavia tutta, aveva sopravanzato e travolto gli argini del racconto fittizio rimandando l’appuntamento col romanzo decisivo di una vita.
L’universo perduto, si capisce, non può essere rievocato facendo unico affidamento al ricordo di esperienze reali, il sogno avendo preso possesso delle zone lasciate in ombra dalla memoria. Composto dell’uno quanto dell’altra, esso vive ormai di strutturali contaminazioni e mescolanze fra realtà e immaginazione, autobiografia e finzione. Siamo giunti quasi alla condizione di chiederci, con Bettiza, se quell’universo sia davvero esistito, tanto lontano appare nel tempo. Il dubbio, l’incertezza, l’evanescenza permeano le vicende di Marco Razmilo, giovane discendente di una dinastia di imprenditori e poi industriali dalmati, per tutto l’arco temporale della narrazione: dal biennio 1943-’45, col succedersi, in “Illiria”, dell’occupazione tedesca a quella italiana, con le ultime sanguinose code di guerra, la vittoria di Tito, la nascente instaurazione della società comunista e l’esilio obbligato; al «colpo di Stato letterario» (così viene definito intorno a pagina 400) che dà pretesto al ritorno improvviso di Marco nella sua città, trent’anni dopo, e al conseguente trauma per l’impossibilità di riconoscere una terra tanto mutata (leggi: balcanizzata). Dubbio, incertezza, evanescenza: in presa diretta come a distanza di decenni, Razmilo non sa dire se ha visto davvero l’amata-odiata Tasja – forse spia dei tedeschi, forse dei comunisti, forse donna di tutti e di nessuno – spogliarsi fino all’estrema nudità davanti all’amico-rivale Matej Rendić. Né se, e fino a che punto, il loro triangolo amoroso sia stato il risultato voluto di un gioco organizzato dal lascivo Maestro Igor Pertić-Perty, alla ricerca di vie sempre più stravaganti per ovviare all’impotenza galoppante. Soprattutto, non saprà mai dire se la sua attrazione erotica e la bruciante gelosia siano divampate nei confronti dell’androgina Tasja, che gli fu sottratta da Matej; o piuttosto non abbiano avuto per oggetto proprio il bellissimo Matej, che gli fu rubato da Tasja.
La qualità impalpabile, indefinita e onirica dell’universo perduto è la stessa che sottende all’adolescenza degli esseri umani. Fase di passaggio, o per meglio dire di trapasso (di acme della vita, cioè di contiguità con la morte), in cui nulla – al di fuori o all’interno di se stessi – appare netto, sicuro, stabilito. Tutto è malcerto e minato da continui sospetti e ripensamenti; è misto e molteplice. Agli occhi di Marco, Tasja è quasi stordente nella sua volubilità: «ebbe l’impressione di riscoprire ancora una volta una donna diversa – recita un passo del romanzo – non più apatica o stanca; ma impaziente, trepida, nervosa […]. Pensò allora che il senso d’irrealtà promanante da quelle sembianze di nuovo mutate, avesse un oscuro legame con una stagione effimera, senza nome, una stagione incompiuta, da lui attraversata di corsa con l’affanno di un fuggitivo».
L’indistinta e precipitosa giovinezza di Marco Razmilo, che avverte e si sconcerta dell’inafferrabile natura plurima di tutte le cose, è la metafora dell’anima dell’universo perduto: della terra estinta: la Dalmazia mistilingue e multietnica appartenuta a un tempo che non è più. Di quell’incrocio di nazionalità, etnie, parlate, di quella miscela di scaglie d’Europa costipate sulla costa orientale dell’Adriatico, oggi è rimasto soltanto il vacillante ricordo, la nostalgia di un’Illiria incantata e senza tempo. Enzo Bettiza è una delle ultime voci ancora viventi capaci di condurci in quell’universo perduto, con intelligenza e grazia: ci sarebbe di che sentire riconoscenza. Durante un litigio col duro e ostinato Matej, Marco Razmilo esclama: «la nostra vera e più profonda radice è bilingue e spesso trilingue: il bilinguismo anche mentale, anche psichico, è la ricchezza e la debolezza della nostra identità fragile e proteiforme. In una parola, della nostra non identità». È noto che l’autore mai è stato gradito dai nazionalismi d’ogni sponda.
Quella che promana da Il libro perduto, in definitiva, è tipica letteratura mitteleuropea del Novecento. Perché non può fare a meno di porre al suo centro il tema dell’identità. Scaturendo da terre frammiste e plurali, scandagliandone lo spirito mosso ed eterogeneo, facendosi carico dell’eredità (d’avanguardia e di tramonto a un tempo) dell’Impero absburgico, gli esiti migliori di quella letteratura hanno rappresentato e messo a nudo lo scandalo dell’identità novecentesca tout court: la sua disintegrazione dopo il tracollo della modernità. Come il recente Alla cieca di Claudio Magris, anche Bettiza, nel suo nuovo romanzo, ripropone e si riallaccia alle problematiche di questa grande tradizione letteraria; e proprio in quanto lo fa indirettamente, in forme che appaiono non calcolate, ma sinceramente patite e autentiche, il risultato che qui raggiunge è superiore rispetto a quello ottenuto da altre prove in passato. Di esse, va da sé, sopravvivono lo straordinario ingegno affabulatorio, la liricità e la limpidezza della prosa, l’elegante l’ironia.
«Ricordo le parole che in proposito mi diceva il nonno, poco prima di morire, parole che allora stentavo a comprendere e che adesso mi tornano più chiare alla mente. Diceva che noi illiri parliamo più lingue, nessuna delle quali è la nostra, che pratichiamo più religioni senza credere in nessuna, diceva che siamo polvere rara, polvere ibrida e mutevole, che s’insinua e sparpaglia fra più mondi senza appartenere a nessuno in particolare».
Patrick Karlsen
EDIZIONE ESAMINATA E BREVI NOTE
Enzo Bettiza, Il libro perduto, Mondadori, Milano 2005.
L’autore ha rivolto gran parte della sua attività di giornalista, narratore e saggista alla riflessione sul destino dell’Europa moderna. Tra i suoi libri: La campagna elettorale, Il fantasma di Trieste, L’anno della tigre, I fantasmi di Mosca, Esilio. Ha curato l’Introduzione al Meridiano Mondadori dedicato a Guido Piovene.