1984, di George Orwell
Chissà quanti fra i telespettatori sedotti a milioni dal Grande Fratello, principe di tutti i reality show, hanno un’idea di cosa esprima, quel nome, nel libro che l’ha originariamente coniato. In 1984 di George Orwell il Grande Fratello è il capo del Partito, forse neppure una persona in carne e ossa ma piuttosto un’essenza, simbolico concentrato del potere. L’epiteto vuol comunicare una sua partecipazione intima, quasi familiare nella vita di ciascuno; tale entità non è propriamente ritratta, è, a dir meglio, rappresentata nelle anonime fattezze di un volto, enormi riproduzioni del quale campeggiano a ogni cantonata, sin dentro ogni abitazione e il cui sguardo è ossessivamente persecutorio. Telecamere, di certo, son posizionate dietro i monitor a loro volta visibilmente installati, si direbbe, in tutti i luoghi ove sia prevista una qualche attività umana; ma non mancano telecamere nascoste ovunque sia ritenuto opportuno. Il Partito, insomma, in tanto è in quanto spia; il potere trae una delle sue primarie fonti dall’atto del vedere.
È facile evincere che di qui abbiano preso spunto i creatori del format televisivo oggi di così largo successo, per assegnare a esso quel titolo e non un altro. I telespettatori hanno facoltà di osservare, ventiquattr’ore su ventiquattro, i concorrenti dello show e di stabilire delle loro sorti nello svolgimento del “gioco”. Spiano e decidono: proprio in quanto guardano, essi hanno potere. Questo evidentemente è il paradigma concettuale, questo il parallelismo proposto con ciò che è descritto nel libro di Orwell.
Purtroppo però vi sono fondati sospetti che lo schema funzioni così solo in modo apparente, e che tra agente del potere e suo oggetto, tra coltello e manico la relazione reale sia esattamente l’inversa. Non occorre, plausibilmente, aver letto Popper per intuire come l’influenza non sia degli spettatori sul mezzo televisivo, ma piuttosto il contrario. La televisione, in una società consumistica, serve prima di tutto a dettare orientamenti di mercato, ed è perciò inevitabile, anzi necessario che essa s’introduca nelle coscienze per produrvi massificazione e conformismo; senza la televisione la società consumistica quale noi la conosciamo non esisterebbe, proprio perché su di quella essa si è storicamente determinata e sviluppata. Nuovi media, Internet in particolare, non sembrano in grado di modificare il quadro; anzi il Web sta plasmandosi secondo canoni e forme proprie del medium televisivo, veicolando sempre più contenuti audio-immagine e sempre meno parola scritta.
Amelie Nothomb – la scrittrice belga che molti son pronti a collocare fra i vertici della letteratura europea contemporanea – ha da poco pubblicato un romanzo, Acido solforico, in cui s’immagina un reality show ambientato in un lager. Il potere totalitario, ha spiegato Hanna Arendt, è quel tipo di coercizione che non si limita a prescrivere ciò che devi fare, ma mira a estendersi a ciò che devi volere e pensare. Nel libro di Nothomb, ecco allora che avviene la sutura fra il luogo-simbolo del totalitarismo novecentesco, il lager, e il luogo che, nelle forme virtuali del reality show, minaccia di divenire il simbolo del totalitarismo contemporaneo, incarnato dalla televisione. In interviste seguite all’uscita del romanzo, la stessa Nothomb ha dichiarato che, dei reality, ciò che più la spaventa non è il processo d’identificazione che quei programmi p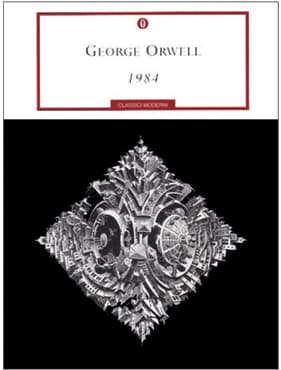 ossono eventualmente favorire in chi li guarda; ma un processo contrario, di differenziazione, quel senso di superiorità che emergerebbe spontaneamente nello spettatore nei confronti dei concorrenti (“io non sono così, io sono meglio”). Un processo che indurrebbe a un conformismo in negativo, di riflesso, ancor più pervasivo: il reality sarebbe lo specchio deformato in cui, per contrasto, si autocelebra la norma di una collettività.
ossono eventualmente favorire in chi li guarda; ma un processo contrario, di differenziazione, quel senso di superiorità che emergerebbe spontaneamente nello spettatore nei confronti dei concorrenti (“io non sono così, io sono meglio”). Un processo che indurrebbe a un conformismo in negativo, di riflesso, ancor più pervasivo: il reality sarebbe lo specchio deformato in cui, per contrasto, si autocelebra la norma di una collettività.
In effetti, si può pensare che il fascino dei reality non sia in nient’altro che nella morbosità di un guardare non visti, con la conseguente presunzione di potenza sull’oggetto guardato che quell’atto comporta. È un sentimento sottile e umanissimo, scandagliato in lungo e in largo nella poetica cinematografica di A. Hitchcock e che ci fa tornare, chiudendo il nostro periplo, direttamente a 1984 di Orwell. Anche in esso il Partito guarda, non visto. Nella distopia (il contrario di utopia) orwelliana il mondo è ormai diviso in tre soli superstati, tutti organizzati politicamente in mostruose dittature che s’ispirano a varianti del comunismo. Londra è capitale di uno di essi, l’Oceania, nella quale vige il Socing, il socialismo inglese con a capo il Partito controllato dal Grande Fratello. Winston Smith, funzionario del Ministero della Verità preposto all’alterazione di vecchi articoli del “Times” non conformi alla verità storica comoda al Partito, è forse l’ultimo uomo d’Europa, ipotizza Orwell, a maturare contro di esso una disperata eterodossia. Assieme all’amata Julia andrà incontro a una ribellione dagli esiti prevedibili nella sostanza, non nella folle crudeltà della loro espressione.
Il contenuto del libro è certo legato alle intenzioni contingenti dell’autore, nella fattispecie di denunciare il pericolo del totalitarismo sovietico incombente sull’Europa quando, nel 1948, il romanzo fu scritto. (Fu ribaltando le ultime due cifre di quell’anno che Orwell ottenne l’epoca in cui è proiettata la vicenda). Ma 1984 dice dell’eterno tentativo di salvare la propria umana dignità di fronte a ogni potere disumanizzante, e in ciò diviene un classico, offrendo come tale intuizioni ancora e sempre valide. Oggi, accade così di rabbrividire leggendo non solo della soffocante preponderanza assunta, nell’universo di 1984, dai mezzi di comunicazione e in particolare da quello televisivo; ma altri e numerosi sono i passi del libro che trasmettono, nel lettore contemporaneo, inquietanti sensazioni di déja-vu. La guerra descritta come condizione permanente ed evento periferico, funzionale al mantenimento delle strutture socio-economiche esistenti. Le masse tenute in uno stato d’intontimento, suggestionate dalla propaganda mediatica e blandite con lotterie supermiliardarie. Le periodiche apparizioni televisive del Nemico, che terrorizza con le sue minacce e convoglia l’odio del popolo. L’esigenza, propria a qualsiasi potere involuto, di manipolare il passato, nascondere o deformare il vero, diffondere ignoranza. La creazione di una neolingua, gergo tecnico che dà il segno di un irreparabile impoverimento del linguaggio, cui corrisponde l’impoverimento del pensiero.
«La guerra è pace. La libertà è schiavitù. L’ignoranza è forza», in 1984 sono gli slogan del Partito. Caduta l’Urss, negli ambienti della politologia anglosassone circolava il detto «Orwell’s prophecy has been defeated», la profezia di Orwell è stata sconfitta. Ciò è sicuramente vero per il secolo XX ma è da dimostrare per il XXI, essendo 1984 un monito che andrebbe tenuto sempre presente da qualunque società che voglia evitare l’imbarbarimento, la propria estinzione come soggetto di civilità. Il grande libro di Orwell resta uno specchio deformato che non consola mai, sul quale misurare la bontà della nostra norma.
Scrisse la figlia di Benedetto Croce: “(…) Fui perciò piuttosto turbata dal fatto che mio Padre, per nulla amatore di letteratura avveniristica e profetica, e neanche di favole moralistiche, desse tanta importanza a quel libro: in particolare alla profezia sulla progressiva eliminazione dell’umanità dal linguaggio, e al punto di esprimere riflessioni pessimistiche – che non gli avevo mai sentito fare nemmeno durante il fascismo – sulla facilità con cui può venire estirpata la pianta della civiltà, che impiega secoli per ricrescere. Quel ricordo, e con esso l’immagine che si ha in quel libro del popolo come ultima risorsa umana, se pure ridotta allo stato puramente vegetativo (vegetazione che inoltre la civiltà dei consumi si preparava a distruggere…), mi lasciarono nel subconscio la certezza che Orwell era un autore il quale non aveva fatto il suo tempo, ma si sarebbe dovuto tenere di riserva per tempi più duri” (Elena Croce, “George Orwell”, in «Settanta», n. 22, Marzo 1972).
Patrick Karlsen
EDIZIONE ESAMINATA E BREVI NOTE
G. Orwell, 1984, Mondadori, I ed. Oscar classici moderni, Milano 200530.
Nuova traduzione dall’inglese di Stefano Manferlotti (2000).
George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair (Motihari, India 1903 – Londra 1950) studiò a Eton e appena ventenne si arruolò nella polizia imperiale britannica in Birmania. Scosso dall’esperienza, lasciò il servizio nel 1928 e prese a peregrinare tra Parigi e Londra impiegandosi in umili professioni, deciso a dedicare anima e corpo alla letteratura. Volontario nella guerra di Spagna sul fronte anti-franchista ebbe esperienza del comportamento politico delle formazioni comuniste, la cui ideologia egli combatté fino alla morte senza rinnegare le proprie convinzioni socialiste. Collaborò a numerosi periodici (“Tribune” di cui fu direttore, “Observer” tra gli altri). Altre sue opere: Fiorirà l’aspidistra (1936), Omaggio alla Catalogna (1938) che è memoria delle sue esperienze al fronte, La fattoria degli animali (1945) satira immortale della politica stalinista. Morì a Londra per tubercolosi.







