Storia e politica. Risorgimento, Fascismo, Comunismo di Paolo Mieli
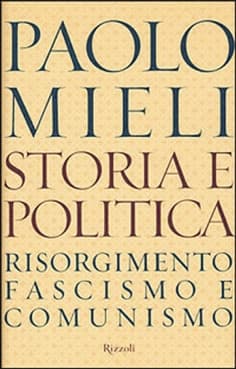 Nel dibattito politico-culturale italiano, negli ultimi anni, è emerso un termine nuovo: «terzismo», che ha goduto e continua a godere di larga fortuna. Lo si usa, per lo più, in chiave polemica: come sostitutivo edulcorato di «cerchiobottismo».
Nel dibattito politico-culturale italiano, negli ultimi anni, è emerso un termine nuovo: «terzismo», che ha goduto e continua a godere di larga fortuna. Lo si usa, per lo più, in chiave polemica: come sostitutivo edulcorato di «cerchiobottismo».
Chi non si schiera, chi cerca di non urtare nessuno e di collocarsi sempre in un punto intermedio rispetto a due posizioni contrastanti, sarebbe un «terzista». Come a dire un opportunista. O peggio, un qualunquista. Questa assimilazione critica del «terzismo» ad atteggiamenti di neutralità “negativa”, è frequente soprattutto a sinistra, nel linguaggio polemico di gran parte della sinistra. Eugenio Scalfari, su «Repubblica», vi ha fatto ricorso molte volte, chiamando in causa alcuni commentatori assai rinomati della stampa moderata. Accusati di nascondere, dietro l’indubbia autorevolezza, una sostanziale mancanza di mordente, e di contrabbandare per oggettività ciò che sarebbe, più che altro, semplice benevolenza verso il potere. Uno di quelli che Scalfari bersaglia più spesso è l’ex ambasciatore Sergio Romano. Ma tante altre firme del «Corriere della Sera», da sponde di sinistra, sono state tacciate di «terzismo», in senso più o meno critico.
Fra loro, quella di Paolo Mieli, direttore del «Corriere». Anche per questo è stato interessante, qualche anno fa, assistere all’incontro televisivo fra lui e Scalfari, organizzato per l’ottantesimo compleanno del fondatore dell’«Espresso», e mandato in onda sul canale satellitare della Rai. I due si conoscono bene. Mieli ha iniziato giovanissimo la sua carriera di giornalista, proprio all’«Espresso». In seguito ha scritto su «Repubblica», prima di passare alla «Stampa»: giungendo anche qui ad assumerne la direzione. In ultimo, l’approdo al «Corriere». Durante la discussione-intervista con Scalfari, Mieli ha avuto modo di chiarire che ciò che molti chiamano «terzismo», in realtà, per lui non è altro che lo sforzo di comprendere le ragioni degli altri: di tutti gli attori in gioco, anche dei suoi oppositori. Senza smarrire la fiducia nelle proprie. Sarebbe la volontà di preservare le condizioni di una dialettica civile e costruttiva; di sfuggire alla faziosità. E, non meno importante, di dare spazio e ascolto alle posizioni più scomode: quelle che per una varietà di motivi non riescono, o non sono riuscite per lungo tempo, a imporsi all’attenzione dei più, a ricevere una considerazione adeguata nel dibattito pubblico.
Il discorso, lo si può intuire, ha diverse implicazioni. Specialmente là dove si consideri che il «terzismo» è stato talvolta visto come l’amplificatore giornalistico del cosiddetto «revisionismo» storiografico. Di «revisionismo», come è noto, si è iniziato a parlare moltissimo a partire dagli anni Novanta. In un’accezione, anche in questo caso, quasi sempre negativa. Alla stregua di un’accusa: lanciata, anche in questo caso, da sinistra a destra. Da storici “di sinistra” contro storici “di destra”. Specie nel nostro Paese ne è sorta una discussione assai accesa, per nulla trasparente, non avara di insincerità e secondi fini. In due parole si può tentare di spiegarla così. Dicendo che la revisione è il sale della storiografia: di più, il suo motore interno. Senza revisione, senza un continuo riesame critico delle interpretazioni acquisite, e delle prove che le hanno sostenute, semplicemente non si dà storiografia. La revisione storica dovrebbe avere, come suo principale fine, la ricerca il più possibile disinteressata del massimo livello di verità, raggiungibile dall’analisi umana e dai suoi strumenti, in merito alle cose del passato. Un concetto fondamentale, questo, della storia come disciplina e come scienza. Che con la destra e la sinistra non ha nulla a che vedere. Diversamente, si accusa una ricerca di revisionismo quando la si ritiene non disinteressata. Quando si ritiene, cioè, che essa abbia operato la revisione di una interpretazione storica acquisita, inseguendo più o meno scopertamente finalità estranee al puro interesse scientifico: finalità di tipo politico e ideologico.
La disputa comunque cambia, nella forma e nella sostanza, in Italia rispetto agli altri paesi europei. L’impressione è che qui sia molto più avvelenata ideologicamente, molto più politicizzata. Intendiamoci: è impossibile una ricerca storica slegata totalmente da una passione, da una dimensione, da una domanda politica. Dal presente si interroga il passato con sempre nuove domande. E chi pone le domande, lo storico, muove da curiosità sulla realtà circostante, sull’attualità del momento: da curiosità in senso lato politiche, insomma. È logico ed è normale. «Accade ovunque, da sempre, a destra come a sinistra», scrive infatti Mieli, che «politica e storia sconfinino l’una nel territorio dell’altra». Ma qui da noi, tuttavia, il dibattito sul revisionismo presenta chiaramente aspetti patologici. Collegato com’è a esigenze politiche strettamente, angustamente contingenti. Perché non ha solo ricadute o significati secondari di natura politica: è parte integrante di una battaglia politica. Di conseguenza, quella che altrove in Europa non fuoriesce, di norma, dai recinti di una discussione culturale e accademica, nel rispetto di linguaggi e stili relativi, in Italia diventa una fase tra le tante della rissa fra sinistra e destra – con tutti i corollari di linguaggio e stile relativi.
Secondo Mieli, si tratta di «una partita primitiva fatta di berci, colpi sotto la cintura, aggressioni alla persona». «Allorché qualcuno accusa qualcun altro di “revisionismo” è come se fosse comparso il segnale che è venuto il momento in cui si mette da parte il confronto delle idee e si sale sul ring». In particolare, sostiene l’autore, non appena il «naturale sconfinamento» della politica nella storia «non viene dalla sinistra più ortodossa, genera […] un clima di sospetto e intolleranza». Come mai?
Dobbiamo renderci conto che la nostra nazione sta attraversando una fortissima crisi di identità. Tra anni Ottanta e Novanta, come sappiamo, è crollato il sistema politico che aveva retto il paese per tutto il dopoguerra, è collassata quella che è stata chiamata la «Repubblica dei partiti»: la “prima” Repubblica. Uno stravolgimento politico che non ha avuto eguali in Europa occidentale. Da allora, noi italiani stiamo vivendo un confuso stadio di assestamento, siamo immersi in un tumultuoso processo di ridefinizione della nostra fisionomia collettiva. Si capisce come questo processo avvenga, non possa non avvenire, solo attraverso un ripensamento dei momenti più importanti della nostra storia, una rilettura in profondo dei caratteri che più l’hanno segnata. Su tutti, il Risorgimento, il fascismo e l’antifascismo, la Resistenza, il comunismo e l’anticomunismo.
«Non passa giorno che in Italia non si abbia un’accesa discussione su questi temi e più in generale sui centoquarant’anni di vita del nostro Stato unitario. Se il confronto su tali questioni fosse sì stringente ma tranquillo, non ci sarebbe niente di male. Anzi: sarebbe la certificazione della vitalità di una coscienza pubblica diffusa […] la prova dell’esistenza di un ethos della nazione».
E invece… Il fatto è che c’è in gioco il rapporto con il nostro passato, la ricostruzione della nostra memoria pubblica, rituale, “ufficiale”: per usare un’espressione un po’ enfatica, l’identità della nazione. Destra e sinistra, oggi, s’incontrano e confliggono in questa opera di edificazione e ridisegno. La “prima” Repubblica aveva costruito la sua memoria “ufficiale” a partire dall’esperienza della lotta di Liberazione: si era detta nata dalla Resistenza e proclamata antifascista. La cultura di sinistra, in generale, aveva intrattenuto un rapporto speciale con quella memoria. Era stata determinante nel definirla, nell’alimentarla, nel celebrarla. Aveva voluto dimostrare l’esistenza di un legame ideale, di un unico filo conduttore tra la Repubblica, l’anima democratica del Risorgimento e le grandi realizzazioni della Rivoluzione francese. Si era impegnata, cioè, in un’imponente costruzione intellettuale, in un affresco che doveva mostrare la storia d’Italia procedere verso gradi sempre maggiori di sovranità popolare, verso la conquista finale della democrazia: seguendo tappe progressive, l’ultima delle quali doveva essere appunto la Resistenza. Una costruzione intellettuale, si è detto: con i suoi protagonisti e i suoi eroi, le sue predilezioni politiche e ideologiche. Ma anche con le sue forzature, le sue mitologie e le sue retoriche; le sue dimenticanze e le sue reticenze.
Oggi, dice Mieli, un gran numero di ricerche che vengono definite «revisioniste», in realtà, non fanno altro che rivisitare criticamente quelle mitologie, e cercano di colmare quelle reticenze. Per rifarci alla distinzione abbozzata più sopra, sarebbero opere di sana revisione, che una parte della cultura di sinistra, sentendo aggredito il suo patrimonio culturale, bollerebbe strumentalmente come «revisioniste».
«Qui da noi l’intreccio tra politica e storia ha prodotto qualcosa di esiziale. Perché non si è risolto nel fecondo rapporto tra l’ovviamente mutevole punto di vista sull’oggi e il riesame delle vicende di ieri, bensì si è imposto come dogma del presente che restringeva il campo visuale del passato. Come se ci dovessimo continuamente difendere da un pericolo. Dal rischio che una ricerca – sia pure la più stravagante, la più bizzarra – potesse mettere a repentaglio qualcosa di prezioso per il nostro vivere civile. E invece niente è più pericoloso di questo atteggiamento sanzionatorio. Si aprano tutti i libri, si discutano con garbo le tesi più diverse dalle nostre. Si rifugga […] dall’uso improprio e calunnioso dell’aggettivo “revisionista”. Si renda comunque omaggio a chi ha impegnato del tempo per pensare, elaborare, scrivere. E tutti avremo una vita migliore».
È un entusiasmante manifesto di spirito liberale e buon senso. Per moltissimi aspetti Mieli ha pienamente ragione. E diversi saggi del suo libro mettono in luce efficacemente i punti contraddittori, le esagerazioni, le lacune, le trascuratezze, che la cultura di sinistra ha accumulato in relazione ad alcuni episodi e problemi della storia nazionale. Certe letture deformanti del rapporto tra Rivoluzione francese e Risorgimento, per esempio. O le cappe di retorica che hanno avvolto alcune narrazioni della Resistenza. E poi, e soprattutto, i ritardi, le vaghezze e i tentennamenti con cui si sono denunciati i crimini del comunismo.
C’è da concordare con Mieli che revisioni in questo senso non possono che essere salutari. Lo stesso Mieli sembra trascurare, però, l’ipotesi che anche qualcuna di quelle revisioni possa nascondere obiettivi politico-ideologici. Che alcune di esse, cioè, pure nate in opposizione a interpretazioni ideologiche di parte, finiscano in realtà per operare una loro sostituzione con un’altra, di segno opposto. E passino così dalla revisione al «revisionismo». Una distinzione che a mio parere resta – l’autore non me ne vorrà – un ottimo strumento di discernimento. Tanto più utile, si badi, in un clima come quello attuale in Italia, che abbiamo visto essere di grande incertezza e teso alla precisazione di una nuova identità nazionale. Ecco, proprio alla crisi d’identità che sta colpendo il nostro Paese, nell’analisi di Mieli manca il più piccolo riferimento. Come pare che manchi, in generale, una riflessione capace di distinguere tra storia e memoria, cioè tra la memoria collettiva di una nazione e la sua memoria pubblica. Infatti, se la prima deve saper abbracciare il passato nella sua interezza, la seconda deve essere per forza selettiva: perché è da essa che si promana l’ethos della nazione, il suo universo di valori. Approfondire e rivisitare la storia di un paese, non significa confonderne la memoria pubblica e i valori fondanti. Rileggere criticamente il Risorgimento e la Resistenza, per esempio, non deve voler dire ripudiarne gli ideali. Nel qual caso non si farebbe solo storia, ma politica in senso stretto; non si farebbe una revisione, mi piace dire, ma del «revisionismo».
Paolo Mieli, Storia e politica. Risorgimento, fascismo, comunismo, Garzanti, Milano 2001.
L’autore (Milano, 1949) si è laureato con una tesi sul fascismo sotto la guida di Renzo De Felice. Nel 1999 ha pubblicato Le storie, la storia. Attualmente dirige il «Corriere della Sera».
Patrick Karlsen






